TRASMISSIONI SERIALI
|
TRASMISSIONI SERIALI |
|
4.3. Interfaccia seriale EIA RS-232C
Questo paragrafo descrive le caratteristiche della trasmissione seriale relativamente al livello fisico del modello ISO/OSI.
Nella trasmissione seriale il collegamento fra trasmettitore e il ricevitore si può realizzare con un minimo di due fili: il primo rappresenta la linea su cui viaggiano i bit, l'altro il filo di massa. Le trasmissioni seriali si dividono in:
1) sincrone;
2) asincrone.
Nelle trasmissioni sincrone il trasmettitore invia degli impulsi di clock contemporaneamente ai bit di informazione in modo da consentire al ricevitore la corretta lettura dei dati in arrivo ad intervalli regolari di tempo scanditi dal trasmettitore.
Il collegamento, concettualmente, si realizza con 3 fili (clock, bit e massa) come in fig.6.
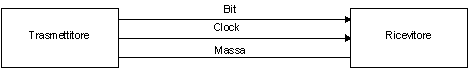
Fig. 6. - Schema a blocchi di una trasmissione seriale sincrona.
In realtà si utilizzano due fili poiché i segnali di sincronismo si inviano sulla linea dati in coerenza col protocollo utilizzato.
Se la trasmissione sincrona avviene tra un modem e l’interfaccia seriale di un computer, il clock può essere generato dall’interfaccia seriale o dal modem stesso.
Se i dispositivi collegati sono due modem, il segnale di sincronismo è contenuto nella tensione analogica che il modem trasmettitore invia al ricevitore; quest’ultimo, attraverso l’operazione di demodulazione, estrae il segnale digitale che contiene particolari caratteri che consentono di sincronizzare il ricevitore al trasmettitore.
I dati sono inviati in blocchi di decine o centinaia di caratteri.
Ogni blocco è preceduto da caratteri di sincronismo e seguito da caratteri di controllo CRC (Codice Ciclico di Ridondanza), per la correttezza della trasmissione, e da un carattere che indica la fine del blocco trasmesso.
In fig.7 si mostra il blocco di caratteri che transita in una trasmissione seriale sincrona tra due modem.
Fig. 7. - Formato del blocco di caratteri in una trasmissione seriale sincrona tra due modem.
Nel collegamento seriale asincrono non si trasmette il clock ma il ricevitore genera un clock locale della stessa frequenza del trasmettitore.
Affinché i due clock risultino in fase, occorre che il ricevitore sappia quando ha inizio la trasmissione di un carattere in modo da sincronizzare la lettura dei vari bit.
In pratica un carattere in trasmissione è preceduto da un bit di start e seguito da uno o più bit di stop.
Il bit di start è costituito dal livello logico 0 mentre il bit di stop dal livello logico 1.
In assenza di trasmissione si ha il livello logico 1; quando la trasmissione ha inizio, l'applicazione del bit di start genera un fronte che sincronizza il clock del ricevitore.
Successivamente sono inviati in sequenza, ad intervalli regolari di tempo, i bit del carattere da trasmettere nel codice ASCII a 7 o 8 bit seguito, eventualmente, da un bit di parità pari o dispari e da uno o due bit di stop.
Le modalità di trasmissione, ovviamente, devono essere note prima che questa sia attivata.
Un sistema che trasmette a 9600 bps (bit per secondo) con 8 bit per carattere senza alcun bit di parità ed un solo bit di stop può trasferire fino a 960 caratteri al secondo poiché un carattere è costituito da 10 bit: 1 bit di start, 8 bit di dato, 1 bit di stop.
In fig.8 si mostra l'analisi temporale della trasmissione del byte 94H supponendo di attribuire al valore negativo di tensione (denominato mark) il bit 1 e al valore positivo di tensione (denominato space) il bit 0.
Le associazioni scelte sono, pertanto, in logica negativa come stabilito dalle raccomandazioni V.1 e V.4 dell’ITU-T.
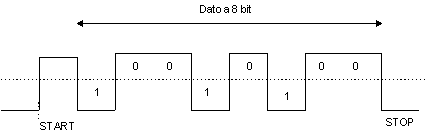
Fig. 8. - Temporizzazione della trasmissione del byte 94H senza bit di parità e con un solo bit di stop.
Il trasmettitore presenta nello stadio di uscita un circuito in grado di effettuare la conversione di un carattere dalla forma parallela a quella seriale in modo del tutto simile ad un registro a scorrimento con caricamento parallelo ed uscita seriale (PISO).
Il ricevitore, invece, presenta nello stadio d'ingresso un circuito in grado di trasformare un carattere ricevuto da seriale a parallelo.
Ciò si realizza con una soluzione simile ad un registro a scorrimento con caricamento seriale e uscita parallela (SIPO).
Vi sono circuiti integrati in grado di comportarsi, all'occorrenza, sia da SIPO sia da PISO, presentano un clock locale che può essere selezionato sul valore richiesto.
Essi prendono il nome di USART (Universal Synchronous Asynchronous Riceiver Trasmitter = ricevitore trasmettitore sincrono o asincrono universale) e sono utilizzati sia nei ricevitori che nei trasmettitori.
Gli USART sono convenienti nelle trasmissioni bidirezionali dove i ruoli fra trasmettitore e ricevitore sono intercambiabili.
Le velocità permesse nelle trasmissioni seriali asincrone hanno i seguenti valori espressi in bit al secondo: 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 57600, 115200. Gli USART più recenti consentono velocità maggiori.
L'interfaccia seriale americana EIA RS232-C (EIA= Electronic Industries Associates), corrispondente alla V.24/V.28 dell’ITU-T, è uno standard di collegamento seriale che può essere di tipo sincrono o asincrono tra un dispositivo di comunicazione DCE come, ad esempio, il modem (Data Communication Equipement) e un dispositivo terminale DTE, come, ad esempio, il computer (Data Terminal Equipement) con velocità di trasmissione inferiore o uguale a 19.2Kbps (questo limite è oramai superato).
L'interfaccia è costituita da un insieme di 25 linee, non tutte indispensabili, che trasportano i bit di dati, segnali di controllo e la massa.
Nel collegamento tra un computer ed un dispositivo periferico vengono adoperati dei connettori miniatura tipo D a 25 poli. Sul DTE (computer, ad esempio) si trova la spina (connettore maschio) mentre sul DCE (modem) si trova la presa (connettore femmina). In alcuni DCE (ad esempio, il mouse seriale) manca la presa esterna poiché il cavo di collegamento entra direttamente nell'apparecchiatura.
I tipici dispositivi periferici che si possono collegare ad un computer via RS232 sono il drive per dischetti, la stampante, il modem, il mouse ecc.
In fig.9a si mostra il connettore a 25 poli per la RS-232C le cui caratteristiche meccaniche sono normalizzate secondo lo standard ISO 2110 della International Standard Organization. In molte applicazioni pratiche non si utilizzano tutte le linee ma solo una piccola parte di esse. In tal caso si fa uso di un connettore ridotto a 9 poli come quello in fig.9b.
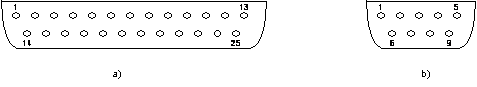
Fig. 9. - Connettore per la RS-232C: a) di tipo a 25 poli; b) di tipo a 9 poli.
Il significato di tali linee sarà descritto nelle pagine successive. Qualunque sia la linea (dati, clock o controlli), il circuito elettrico equivalente di tale interfaccia tra il trasmettitore e il ricevitore è quello indicato in fig.10.
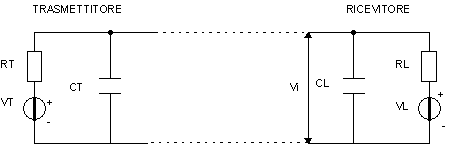
Fig. 10. - Circuito equivalente tra trasmettitore e ricevitore nello standard RS232-C.
|
VT = f.e.m. del trasmettitore a circuito aperto; RT = Resistenza interna del trasmettitore; CT = Capacità equivalente del trasmettitore; CL = Capacità equivalente del ricevitore; |
RL = Resistenza d'ingresso del ricevitore; VL = f.c.e.m. del ricevitore a circuito aperto; Vi = d.d.p. all'interfaccia.
|
In tale standard si definisce mark la tensione Vi di valore inferiore a -3V e si definisce space quella superiore a +3V. Durante la trasmissione si associa il livello logico 1 a mark e 0 a space. Si osserva subito che i livelli logici sono bipolari e in logica negativa (tensione positiva=0; tensione negativa=1). Tipicamente i valori di tensione assunti sono ±12V. La resistenza di carico del ricevitore RL deve essere compresa tra 3KOhm e 7KOhm, la capacità CL in parallelo al carico deve essere inferiore a 2.5nF e la f.c.e.m. VL non deve superare i 2V.
La f.e.m. VT del driver del trasmettitore non deve superare i 25V, RT e CT non sono specificati ma devono essere tali da evitare una corrente di corto circuito superiore a 0.5A e da consentire una Vi compresa tra 5 e 15V.
Poiché la capacità per unità di lunghezza di un cavo è di circa 200pF/metro si evince che la massima distanza tra i dispositivi collegati in tale standard non deve superare i 12-15 metri. In tabella 1 si descrive la piedinatura del connettore a 9 e 25 poli, il nome e la descrizione delle linee della RS-232C.
Tab. 1
|
PIN (9) |
PIN (25) |
NOME V.24 ITU |
NOME RS-232 |
DESCRIZIONE |
|
|
1 |
C101 |
FG |
Frame ground = Massa di protezione |
|
3 |
2 |
C103 |
TxD |
Trasmitted data = Dati in trasmissione |
|
2 |
3 |
C104 |
RxD |
Received data = Dati in ricezione |
|
7 |
4 |
C105 |
RTS |
Request to send = Richiesta di trasmissione |
|
8 |
5 |
C106 |
CTS |
Clear to send = Pronto a trasmettere |
|
6 |
6 |
C107 |
DSR |
Data set ready = DCE pronto |
|
5 |
7 |
C102 |
GND |
Ground = Massa dei segnali |
|
1 |
8 |
C109 |
DCD |
Data carrier detector = Portante in ricezione presente |
|
|
9 |
|
|
Riservato per apparecchi di collaudo |
|
|
10 |
|
|
Riservato per apparecchi di collaudo |
|
|
11 |
C126 |
CK |
Scelta frequenza in trasmissione |
|
|
12 |
C122 |
SCF |
Segnale di ricezione presente sul canale ausiliario |
|
|
13 |
C121 |
SCB |
Pronto per la trasmissione sul canale ausiliario |
|
|
14 |
C118 |
SBA |
Dati in trasmissione del canale ausiliario |
|
|
15 |
C114 |
TC |
Transmit clock = Clock di trasmissione dal modem |
|
|
16 |
C119 |
SBB |
Dati in ricezione del canale ausiliario |
|
|
17 |
C115 |
RC |
Received clock = Clock di ricezione |
|
|
18 |
|
|
Non connesso |
|
|
19 |
C120 |
SCA |
Richiesta di trasmissione del canale ausiliario |
|
4 |
20 |
C108 |
DTR |
Data terminal ready = DTE pronto |
|
|
21 |
C110 |
CG |
Rivelatore della qualità del segnale |
|
9 |
22 |
C125 |
RI |
Ring indicator = Chiamata in arrivo |
|
|
23 |
C111 |
CI |
Selezione velocità di trasmissione da DTE |
|
|
24 |
C113 |
DA |
Clock di trasmissione da DTE |
|
|
25 |
|
|
Non connesso |
Per collegare tra di loro due computer con l'interfaccia seriale RS-232 si deve preparare un cavo, noto come cavo null modem, con almeno tre fili (RxD, TxD e GND) e due connettori a 25 poli femmine da porre alle due estremità del cavo.
Occorre, però, fornire i corretti potenziali alle linee di ingresso che non si intendono utilizzare.
In fig.11 si mostra un tipico collegamento ove il pin 5 (linea di ingresso CTS) è pilotato dallo stesso DTE attraverso il pin 4 (linea di uscita RTS).
Analogamente la linea di uscita DTR (pin 20) va collegata ai pin 6 e 8 di ingresso (DSR e DCD, rispettivamente). Ciò vale per entrambi i computer.
In questo modo si "imbroglia" il computer ma si deve rinunciare al collegamento in handshake.
La tecnica dell'handshake (letteralmente stretta di mano) consiste nel sincronizzare il collegamento attraverso due linee di controllo: il trasmettitore invia un livello logico di richiesta di invio (uscita RTS, pin 4) ed il ricevitore risponde con un livello logico di pronto a trasmettere (ingresso CTS pin 5); in pratica si autorizza il trasmettitore ad inviare i dati.
L'imbroglio (collegamento pin 4 e 5 dello stesso connettore) consiste nel fatto che il trasmettitore "autorizza se stesso" ad inviare dati.
Il collegamento dei pin 6, 8 e 20 dello stesso connettore realizza un "imbroglio" similare.
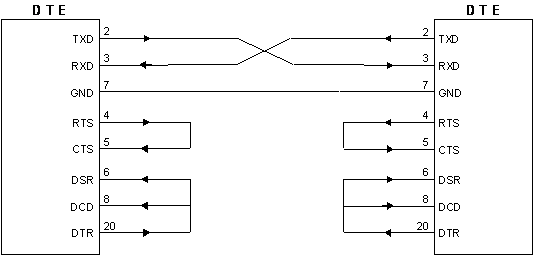
Fig. 11. - Collegamento tra due computer via RS-232C con cavo NULL-MODEM.
Volendo un collegamento con handshake si devono utilizzare almeno 5 fili. In fig.12 si mostra un possibile collegamento.
I due computer, essendo collegati direttamente e non via modem, possono comunicare ad elevata velocità.
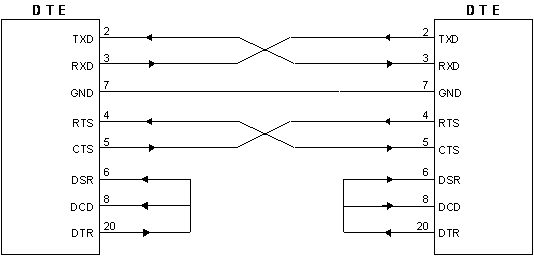
Fig. 12. - Collegamento tra due computer via RS-232C con cavo NULL-MODEM con possibilità di handshake.
4.3. Interfaccia seriale EIA RS-232C
a cura del prof. Giuseppe Spalierno, docente di Elettronica - ultima versione febbraio 2005