S.G. |
Progetto 1A Modulo 3 La multimedialità |
I.T.I.S. "Modesto Panetti" B A R I |
La multimedialità
1. Introduzione
Le informazioni sono veicolate sui mezzi di comunicazione fisici, come l'inchiostro su carta, la pressione acustica generata da un altoparlante, l'immagine che si forma su un monitor, ecc. e nei moderni sistemi di trasmissione esse sono trasformate in segnali elettrici che vengono, poi, digitalizzati, codificati e decodificati.
Le informazioni registrate col l'inchiostro su foglio, ad esempio, spaziano da un nostro scritto realizzato con penna e carta, ai giornali, libri, enciclopedie, realizzati con strumenti tipografici o elettrici.
2. Documenti monomediali e multimediali
Un documento, un prodotto, viene definito monomediale se è realizzato con un solo mezzo di comunicazione.
Esempi di prodotti monomediali sono: documenti di soli caratteri alfanumerici, la radiodiffusione, la telefonia, un album di fotografie, il cinema muto (senza didascalie) o i nostri filmini non sonori realizzati con le vecchie cineprese.
Un prodotto viene definito multimediale se è realizzato da più mezzi di comunicazione, ovvero da più media.
Esempi di prodotti multimediali sono: documenti costituiti da testo e immagini, trasmissioni televisive, un album di fotografie con didascalie, ecc.
I media che rendono multimediale un prodotto sono: testo, immagine, suono, animazione, filmati.
Il computer può consentire la produzione e l'utilizzazione di documenti sia monomediali che multimediali; in quest'ultimo caso il computer deve essere dotato di scheda sonora e di altoparlanti per l'utilizzo di documenti contenenti l'audio e di un microfono o il collegamento ad apparecchiature HI-FI per la produzione di audio. Per l'utilizzo di immagini è sufficiente possedere una discreta scheda grafica mentre per la produzione delle immagini può essere necessario l'impiego di uno scanner o di una telecamera con scheda video.
L'uomo, fin dall'antichità, aveva già prodotto materiale multimediali tramite manoscritti e disegni e, con tecniche più evolute, stampa tipografica ed immagini.
E' indiscutibile, però, che il successo della multimedialità, in particolare l'aspetto coinvolgente e partecipativo, è da attribuire al suono.
Solo di recente l'uomo è stato in grado di catturare e governare, riprodurre e trasmettere a distanza il suono: si pensi al successo ottenuto dalla telefonia, radio e televisione e dalla registrazione sonora su cassette magnetiche e compact-disk.
Attualmente la multimedialità è concepita con un calcolatore che gestisce contestualmente più mezzi di comunicazione, correlati tra loro e veicolati attraverso un unico supporto.
Tutte le applicazioni multimediali presentano due caratteristiche correlate:
Si pensi, ad esempio, e senza ricorrere all'uso del personal computer, ad un articolo di giornale con una o più immagini e ad un album di fotografie con didascalia.
Nel primo caso il medium dominante è il testo e le immagini, in genere, fanno da sfondo, sono un riempitivo, alle volte servono ad integrare il messaggio che si vuole dare (ad esempio la descrizione di un fatto di cronaca avvenuto in una cittadina di un'altra nazione e l'immagine della cartina geografica di quella nazione in cui si evidenzia la posizione della cittadina in cui è avvenuto il fatto di cronaca) ed alle volte se ne può tranquillamente fare a meno ( ad esempio un articolo politico e l'immagine o le immagini dei personaggi politici citati).
Nel secondo caso il medium dominante è l'immagine, cioè le fotografie, e il testo inserito in didascalia fa da sfondo, serve ad inquadrare quando, dove e perché è stata scattata la foto.
Per quanto riguarda la separatezza dei media dell'esempio precedente è evidente che testo ed immagini presentano un linguaggio costruttivo ed organizzativo fra loro diversi.
3. Evoluzione della multimedialità
Tutti i mezzi di comunicazione hanno dimostrato una naturale tendenza ad inglobare i media preesistenti.
E' stato così per la televisione nei confronti della radio, del cinema e del teatro ed ora Internet ed i media informatici.
Questo, però, non significa che i media precedenti siano destinati a scomparire.
L'evoluzione tecnologica dei media ha seguito queste tappe fondamentali:
1837: Samuel Morse inventa il telegrafo
elettromagnetico;
1842: Alexander Bain inventa il fac-simile;
1871: Meucci inventa il telefono;
1877: Thomas Edison crea il primo fonografo;
1892: I fratelli Lumiere inventano il cinematografo;
1897: Marconi sperimenta il telegrafo senza fili;
1912: La Olivetti produce la prima macchina per scrivere
italiana;
1925: John Baird ottiene le prime immagini televisive;
1946: Viene costruito l'ENIAC, il primo calcolatore;
1958: Compaiono i primi circuiti integrati;
1962: Lancio del primo satellite per telecomunicazioni;
1968: Douglas Engelbart inventa il mouse;
1970: L'agenzia americana ARPA sviluppa un nuovo tipo di rete a
commutazione di pacchetto, precursore di Internet;
1973: l'IBM costruisce i primi floppy disk;
1975: Compaiono i primi personal computer;
1978: John Barnaby lancia Wordstar, il più popolare programma di
videoscrittura;
1980: La Philips inventa il CD-audio;
1981: Viene messo in vendita il primo PC portatile;
1981: IBM lancia il personal computer con MS-DOS Microsoft e
processore 8088 Intel;
1985: Microsoft lancia Windows, destinato a diventare il S.O. ad icone più
diffuso;
1992: Il CERN di Ginevra inventa il WWW, sistema
multimediale ad ipertesto che decreta il successo di Internet;
1998: La Microsoft include nel suo nuovo S.O. Windows 98 i
programmi client per navigare in Internet.
4. Ipertesto
Nel precedente paragrafo si è detto che nel 1992 il CERN di Ginevra mise a punto un sistema multimediale ad ipertesto per la consultazione di documenti presenti in Internet.
La nascita dell'ipertesto si deve a Vannevar Bush che, nell'articolo As We May Think (http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/vbush oppure http://www.cel.sfsu.edu/MSP/timeline/Bush1.html ) scritto nel 1945, si chiedeva come organizzare meglio l'enorme massa di conoscenze che la civiltà produce.
Bush, già prima della sua nomina a professore e quindi a dirigente del MIT, aveva concentrato la sua attenzione sui dispositivi analogici preferendoli a quelli digitali. La sua attenzione era attratta dalla capacità delle macchine analogiche di riflettere i fenomeni reali a differenza delle digitali operanti con elementi discreti non necessariamente correlati a ciò che rappresentano.
Bush osservava che la struttura tradizionalmente utilizzata, l'indice semplice o strutturata in sotto indici, non è naturale perché costringe ad un continuo andirivieni tra indice e documento. Il cervello non funziona in questo modo ma per associazioni di idee, per nessi logici tra un'idea e l'altra. Egli proponeva una macchina ideale, mai realizzata, il MEMEX (MEMory EXtender), in grado di immagazzinare testo ed immagini e di creare dinamicamente collegamenti per associazione di idee tra una pagina e l'altra.
Venti anni dopo Ted Nelson riprese l'idea di Bush e coniò il termine ipertesto (hyper-text). Il sogno di Nelson era quello di realizzare un ipertesto universale, equivalente elettronico dell'enciclopedia universale.
"...con ipertesto intendo scrittura non sequenziale", con questa semplice definizione Theodor Holm Nelson riprendeva i suggerimenti del Memex per immaginare una rete planetaria di interscambio delle informazioni e dette vita al progetto Xanadu.
Anche il Xanadu rimarrà un progetto mai realizzato e dopo l'abbandono dell'Autodesk, per anni sua finanziatrice, il progetto decade nel 1994, proprio quando a parere di Nelson mancavano pochi mesi di lavoro per vederlo completato.
La caratteristica degli ipertesti è che al loro interno le parole e le frasi sono collegate non più in modo obbligato e sequenziale come avviene nelle pagine di libro, bensì sulla base di vincoli che qualunque autore o lettore voglia imporre con un tocco di mouse.
Un ipertesto, quindi, è un particolare insieme di nodi e di link.
I nodi sono le pagine visualizzate sullo schermo, i link sono i collegamenti tra le pagine che danno luogo ad una miriade di percorsi tra i vari nodi.
L'utilizzo dell'ipertesto consiste nello spostarsi da un nodo all'altro tramite i link secondo non un percorso obbligato ma secondo una libera scelta dell'utilizzatore.
Il percorso realizzato, scelto dal lettore, consente, così, una sorta di navigazione che rischia, però, di essere ripetitiva, quando si ritorna su un nodo già visitato, e non completa poiché alcuni nodi che, sarebbero importanti per il navigatore, potrebbero risultare mai visitati.
In un ipertesto le pagine non hanno un ordine prestabilito ma sono richiamate dal lettore secondo le proprie scelte ed interessi. Possiamo affermare che l'ipertesto, al contrario dello scritto tradizionale, non ha una sola struttura, ma ne ha molte sovrapposte: lo stesso insieme di informazioni può essere letto secondo un percorso personalizzato. I possibili percorsi, però, sono stabiliti dall'autore.
L'ipertesto non ha una fine, come nei libri: questo può provocare la sensazione di essersi persi e di non essere arrivati a nulla.
Il computer ed Internet consentono l'utilizzo degli ipertesti i quali non vengono letti ma navigati: viaggio e conoscenza tramite l'esplorazione. Internet, grazie alla sua struttura reticolare in grado di connettere risorse diverse, è una forma di ipertesto sui generis.
Tecnicamente un ipertesto elettronico presenta all'interno di un documento (nodo) delle voci calde (hot-word) costituite da parole colorate e sottolineate o da immagini sulle quali la freccia del mouse si trasforma in una manina con l'indice puntato. Cliccando sulla voce calda si attiva il collegamento (link) ad un altro documento che sarà mostrato sul monitor. Il documento è richiamato localmente dalla propria memoria di massa o in modo remoto dalla memoria di massa di un server collegato ad Internet e distante da noi anche di alcune migliaia di chilometri.
Un ipertesto dovrà poi consentire di ripercorrere a ritroso ogni passo del percorso scelto, e in alcuni casi offrire una mappa dove l'utente possa conoscere il punto raggiunto nel contesto generale (history). Quest'ultima funzionalità potrebbe essere trascurata se si considera la definizione di ipertesto come rete e come tale senza la necessità di un inizio e di una fine stabiliti. Nella pratica però, molti degli ipertesti pubblicati finora, sono strutturati secondo un modello gerarchico o multisequenziale.
Si mostrano nelle figg.1, 2 e 3 vari tipi di collegamento di documenti secondo la struttura sequenziale, ad albero ed ipertestuale.
![]()
Fig.1 Struttura sequenziale. Il nodo 1 è quello iniziale e il nodo 4 è quello finale. Il nodo 2 è preceduto dal nodo 1 e seguito dal 3. Il nodo 3, infine, è preceduto dal 2 e seguito dal 4. Il percorso è unico ed obbligato.
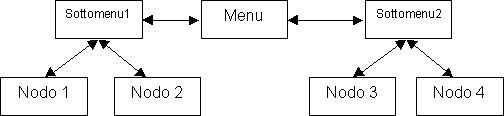
Fig.2 Struttura ad albero. Il menù consente una scelta. I sottomenù consentono di accedere al nodo selezionato. Il collegamento tra nodo e nodo avviene risalendo ai sottomenù. E' possibile scegliere un percorso casuale. In genere ciascun nodo consente il collegamento diretto al menù principale (o home page).
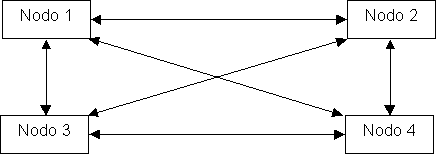
Fig.3 Struttura a maglia completa, tipica di un ipertesto.
Generalmente, nella realizzazione di un insieme di nodi con links, non si utilizza una struttura a maglia completa ma una combinazione tra la lineare, ad albero e a maglia, non sempre completa.
Il prodotto così ottenuto, a rigore, non è un ipertesto secondo la definizione di Nelson.
In Internet vi sono validissimi esempi di ipertesti con documenti ricchissimi di collegamenti ad altri documenti dello stesso autore o di altri autori residenti su server diversi sparsi per il mondo. In Internet abbondano, però, anche documenti non collegati secondo una logica associativa ma collegati con una logica di tipo sequenziale: in pratica il libro classico tradotto in forma elettronica ed inserito sul Web.
Nessuno toglie la validità di un insieme di documenti collegati tra loro da una struttura sequenziale o ad albero ma così si rinuncia alle capacità ipertestuali offerte dal Web: è come percorrere una autostrada utilizzando una bicicletta.
La tecnologia informatica ha consentito di associare al testo, immagini, suoni, animazioni e filmati, cioè la multimedialità.
Un ipertesto (useremo il termine ipertesto per individuare un insieme di documenti collegati non solo secondo una struttura reticolare) può contenere elementi multimediali, come accade nella maggior parte dei documenti presenti su Internet, e quindi, a rigore, dovrebbe essere chiamato ipermedia.
Si vuole precisare però, come osservano alcuni specialisti del settore, che l'ipertesto multimediale non è la semplice somma tra ipertesto e aspetti multimediali ma è una nuova entità in cui le parti componenti non si sommano ma si moltiplicano.
Intanto è possibile effettuare i collegamenti (link) non solo a documenti testuali ma anche a singoli medium inseriti nell'applicazione ipermediale per cui viene meno la caratteristica di dominanza, tipica dei prodotti semplicemente multimediali e si determina un percorso autonomo nell'organizzazione strutturale della comunicazione attraverso vari media e non solo attraverso il testo.
Un utilizzo su grande scala dell'ipertesto, è avvenuto senza una piena consapevolezza da parte dei suoi fruitori. La Microsoft, la più grande casa di produzione di software del mondo, iniziò ben presto a dotare i suoi programmi di "aiuti in linea". L'help, ha lo scopo di aiutare l'utente nell'utilizzo del programma sostituendo (almeno in parte) le solite guide stampate. L'help non può essere modificato dall'utente, ma può essere soltanto consultato di solito in due maniere: o partendo dal sommario dell'ipertesto o compiendo una ricerca per parola.
Se ci poniamo l'obiettivo di creare veramente un ipertesto mondiale detentore di tutto lo scibile umano, dovremo misurarci con enormi interessi di carattere commerciale e con inevitabili riflessi a carattere politico. Attualmente solo il 3% della popolazione mondiale possiede un personal computer, e tra questi solo una piccola parte ha l'accesso ad Internet. C'è poi il problema delle reti telefoniche spesso assolutamente inadatte al traffico in rete, o addirittura assenti in molti paesi in via di sviluppo. Senza una presa d'atto di queste problematiche resteremo lontani dall'ipertesto sognato dai pionieri della materia, ed anzi rischieremo di trasformarlo in uno strumento altamente discriminatorio.
4.1. I sistemi ipertestuali
Riassumiamo le caratteristiche di un ipertesto.
L'ipertesto è un sistema di rappresentazione di conoscenza in cui gli elementi possono essere composti in modi diversi, in accordo con le diverse prospettive degli utenti del sistema.
Un sistema a ipertesto può essere sia dinamico che interattivo. L'utente di un sistema a ipertesto può esplorare un documento in modi non precedentemente determinati dall'autore stesso. I concetti possono essere raggruppati usando un sistema di divisione non necessariamente gerarchico.
Un documento con una struttura ipertestuale che contiene al suo interno multimedia viene definito ipermedia. Oramai i termini ipertesto ed ipermedia vengono usati indifferentemente.
In un ipermedia sono sempre presenti nodi (concetti) e links (collegamenti).
Un nodo, di solito, rappresenta un singolo concetto, o una idea. Esso può contenere testi, grafici, animazioni, files audio, video, immagini o programmi. I nodi sono collegati fra loro tramite i collegamenti, attivandoli (premendo su di esse con il mouse) è mostrato il contenuto di un nodo.
I collegamenti possono essere bidirezionali in modo da facilitare un eventuale ritorno al punto di partenza.
Grazie a questo sistema di nodi e links i sistemi ipermediali costituiscono un metodo di accesso non sequenziale ad informazioni da una varietà di media completamente nuovo rispetto ai metodi tradizionali. A causa della loro struttura non lineare sono facilmente espandibili e rendono possibile un accesso flessibile alle informazioni includendo i concetti di navigazione, annotazione e presentazione personalizzata.
Le caratteristiche di un sistema ipermediale sono le seguenti:
Vantaggi di una presentazione ipermediale.
Innanzitutto l'utente è libero di esplorare e assimilare informazioni in diversi modi, quindi con un unico documento si rendono possibili varie prospettive.
In campo didattico questo risulta molto utile: lo studente può scorrere i vari nodi alla velocità che preferisce. Inoltre, entro certi limiti, è possibile utilizzare lo stesso pacchetto per studenti a differenti livelli. Infatti non è indispensabile passare per tutti i nodi di un documento ipermediale per mantenere il filo di un discorso.
I mezzi elettronici permettono di immagazzinare una grande quantità di informazioni. Con un'unica fonte si può avere a disposizione quanto con supporti tradizionali si poteva ottenere solo sfruttando vari tipi di fonti (libri, video..) Inoltre i documenti possono essere aggiornati molto facilmente e si hanno a disposizione più strumenti per la trasmissione di informazioni.
Grazie ai meccanismi per la ricerca di informazioni è possibile una navigazione rapida e ottenere in breve tempo le informazioni desiderate.
Gli ipermedia sono strumenti che permettono allo studente di esplorare in libertà un certo numero di documenti costruendo così la propria conoscenza.
Oggi gli stessi studenti possono costruire ipertesti e questo permette loro di apprendere materiale didattico e di lavorare in gruppo.
Svantaggi di una presentazione ipermediale.
Lo svantaggio più ovvio degli ipermedia è la necessità del calcolatore. Non sempre una classe è dotata del computer.
Un altro problema subito evidente è la scarsa portabilità rispetto ai documenti tradizionali su carta.
Occorre poi prestare molta attenzione nella costruzione dei links per far si che l'utente non si disorienti facilmente. Durante la navigazione è possibile perdere l'orientamento, cioè non riuscire più a capire dove ci si trova e come fare per andare in un altro posto. Questo è spiacevole in qualsiasi tipo di documento ed è assolutamente da evitare in pacchetti didattici, dove si suppone che l'utente decida sempre consapevolmente dove andare.
Il decidere quale collegamento seguire comporta quella che viene definita spesa cognitiva da parte dell'utente. Questo processo può far perdere tempo ed essere fonte di distrazione. Ovviamente l'entità del problema è proporzionale al numero di links. Va da sé quindi che il valore di un documento ipermediale non aumenta con il numero di ancore, anzi, è preferibile limitare il numero di collegamenti per non creare ciò che viene chiamato spaghetti document.
Un'altra spesa cognitiva è quella dell'autore del documento che deve preoccuparsi dell'organizzazione dell'ipermedia, della creazione dei nodi e relative ancore. Migliore è la qualità del lavoro dell'autore, minore sarà la spesa cognitiva dell'utente.
È stato anche detto che l'uso degli ipermedia come tecnologia per l'insegnamento solleva problemi molto delicati dal momento che materiale di questo tipo non assicura che l'utente riceva un riscontro sufficiente in seguito alle sue azioni. Con ciò si vuol dire che l'utente ha una possibilità ristretta di interazione e questo non assicura il suo pieno coinvolgimento nel processo di apprendimento a livello profondo. Ecco dunque ancora una volta emergere il problema della interattività: è di estrema importanza inserire in un pacchetto didattico passaggi ove venga richiesto esplicitamente l'intervento diretto dell'utente, al fine di ottenere risultati (simulazioni, grafici, disegni...) creati in funzione delle richieste dello studente.
5. I supporti della multimedialità
E' noto che l'audio, le immagini e i filmati occupano tantissimo spazio di memoria rispetto al testo per cui un documento multimediale, ed ancor più un ipertesto multimediale, necessita di supporti molto capienti.
I produttori di materiale multimediale, come enciclopedie, cataloghi, ecc. memorizzano il prodotto su CD-ROM che presenta una capacità di 650Mbyte.
Fino a qualche anno fa si era costretti ad utilizzare dischetti da 1.44Mbyte e quindi si creavano i seguenti inconvenienti:
Nel primo caso l'operazione di installazione dell'ipertesto sul proprio computer risultava piuttosto lunga e non priva di sorprese come, ad esempio, la presenza di un dischetto difettoso che non consentiva la corretta installazione del prodotto.
Nel secondo caso si era costretti a sacrificare il contenuto o la qualità del prodotto: immagini con pochi colori e a bassa risoluzione, audio campionato a bassa frequenza e a pochi bit, filmati quasi del tutto assenti, approfondimenti testuali ridotti al minimo indispensabile.
Il CD-ROM ha consentito di superare questi inconvenienti grazie alla sua elevata capacità: può contenere fino a 300.000 pagine digitalizzate e compresse con immagini fisse o animate, ovvero una enciclopedia di 36 volumi.
La disponibilità dei masterizzatori ha consentito a tutti gli utenti di incidere in proprio i CD-ROM, dal costo di qualche migliaio di lire, e quindi di produrre autonomamente ipertesti multimediali.
Il CD-ROM, tuttavia, è un supporto a sola lettura (Read-Only-Memory) non cancellabile per cui, pur essendo consultabile all'infinito, è immutabile.
Questo è un inconveniente per quelle opere che si aggiornano continuamente per cui un CD-ROM consente all'utente una fruizione limitata nel tempo e nello spazio.
La comparsa sul mercato di CD registrabili più volte consente in parte di superare queste limitazione poiché permette l'aggiornamento del proprio prodotto e il riuso del supporto che, in questo caso, si aggira su alcune decine di mila lire.
Si vuole, infine, citare il DVD (Digital Video Disk) dalle dimensioni identiche al CD-ROM (120mm. di diametro) in grado di memorizzare una quantità sconfinata di dati: a 4.7Gbyte a singola faccia, 8.5Gbyte a doppia faccia. I lettori di DVD supportano tutti gli standard dei compact disk finora disponibili in commercio: CD-audio, CD-ROM multisessione, CD-I, ecc.; alcuni di essi possono anche incidere il supporto per cui si potranno realizzare su un solo supporto opere sconfinate di ottima fattura tecnica (la qualità del contenuto, però, dipende sempre dalla competenza e dall'abilità degli autori).
6. Prodotti off-line e on line
In conclusione possiamo affermare che la tecnologia del CD-ROM consente di consultare i prodotti da un'unica postazione di lavoro e sono immutabili nel tempo; per questo tali prodotti sono detti off-line.
Il multimediale è pronto a passare alla fase successiva delle applicazioni on-line.
I prodotti di intrattenimento, educativi e di informazione saranno messi a disposizione dell'utente in forma elettronica, costantemente aggiornati e immediatamente disponibili senza limitazioni di capacità di memoria.
Questo sarà possibile subito dopo il 2000 quando le reti di telecomunicazioni saranno trasformate a larga banda. Oggi Internet consente, ad un utente privato, collegamenti a 64Kbyte o a 128kbps (due canali ISDN in bonding). Questa velocità non è sempre garantita a causa del traffico eccessivo presente su alcuni nodi in cui transitano i dati a noi destinati. Il trasferimento di file dell'ordine di alcune decine di Mbyte comporta una attesa di alcune decine di minuti e non sempre un utente è disposto a sottostare a tale attesa. Tale banda, inoltre, è insufficiente per vedere film in tempo reale ad elevata qualità.
7. Ipermedia e didattica
Un altro settore in cui le tecnologie ipertestuali e ipermediali hanno buone prospettive di consolidamento è quella dei sistemi didattici o di formazione. Quando si parla di apprendimento col supporto del computer - computer-based learning (CBL) - occorre distinguere tra sistemi tutoriali, in cui l'apprendimento è rigidamente guidato attraverso il controllo del dialogo e della strategia didattica, e sistemi che forniscono occasioni esplorative, cioè che incoraggiano il discente a muoversi tra concetti e documenti usando una serie contenuta di strumenti.
Si contrappongono allora le tecnologie dell'intelligenza artificiale, che producono sistemi tutoriali intelligenti - in grado di svolgere la propria funzione attraverso la definizione esplicita del livello di conoscenza dei discenti e degli esperti -, e le tecnologie ipermediali, che rendono possibile lo sviluppo di sistemi didattici volti a garantire libertà di movimento all'interno delle basi informative, la scoperta autonoma di relazioni e la creazione di reti associative integrate, secondo le esigenze di apprendimento dell'utente.
Tuttavia, entrambi i tipi di sistemi si sono dimostrati non del tutto efficaci o per la loro eccessiva rigidità o per la troppo evidente destrutturazione, così approcci più recenti a sistemi CBL stanno facendo riconsiderare in modo critico questi due standard. Il modello per tutorial intelligenti sta evolvendo verso sistemi che si configurano come consulenti, con tecniche di apprendimento guidate, mentre i sistemi di tipo ipertestuale tendono ad essere corredati di strumenti che applicano una qualche forma di controllo tutoriale. Per evitare inoltre la condizione di smarrimento, si vanno sviluppando strumenti di supporto alla navigazione, di sostegno più diretto, attraverso link gestiti con procedure che si basano sull'intelligenza artificiale.
8. Luci ed ombre della multimedialità
La multimedialità promette all'uomo un futuro migliore o peggiore ?
A questa semplice domanda non è possibile dare una risposta univoca e precisa perché tanti sono i fattori che giocano a favore o a sfavore della multimedialità. Sarà il futuro a stabilire l'evoluzione dei pro e dei contro la multimedialità.
Cerchiamo di esaminare qualche aspetto.
Definiamo con comunicazione multimediale la collaborazione di più forme di comunicazione che utilizzano le "autostrade informatiche".
Oggi questo è possibile grazie alle reti geografiche private e pubbliche su cui spicca Internet.
Prima della televisione le comunicazioni a distanza erano monomediali:
Prima dell'uso del computer nella telematica le comunicazioni, a parte il telefono, erano unidirezionali.
Il telefono, tuttavia, pur consentendo una comunicazione bidirezionale, è del tipo uno-ad-uno e non uno-a-molti.
Internet rappresenta un mezzo di comunicazione in cui tutti possono comunicare con tutti.
Tutti i mezzi di comunicazione finora conosciuti, i giornali, la radio e la televisione, sono unidirezionali: pochi scrivono o parlano e molti leggono o ascoltano.
Col computer è possibile ricevere programmi televisivi e radiofonici, posta elettronica, videotelefonate, quotidiani aggiornati, lezioni universitarie e non, conti bancari, acquisti on-line, ed è possibile anche interagire con i propri interlocutori via testo, audio o in videoconferenza. Quest'ultima possibilità consente di evitare continui spostamenti fisici da una città all'altra con evidente risparmio di tempo e denaro per spese di trasporto e residenziali.
Fra i pericoli della multimedialità citati da alcuni è da annoverare la progressiva rarefazione dei contatti verbali e umani in misura maggiore rispetto a quanto ha determinato la televisione.
In realtà la vita virtuale che la multimedialità prospetta può solo ampliare la nostra realtà fisica ma non sostituirla.
Le cartelle selezionabili trattano vari argomenti: WWW, posta elettronica, FTP, come si naviga, come collegarsi, TELNET, dimesione sociale, mercato globale, ecc.
Appendice
Si riportano alcuni interventi da maggio a luglio 98 nella mailing list Didaweb sulla multimedialità:
Alle numerose risposte per il collega Piccolo che chiedeva informazioni su ipertesti e ipermedia, vorrei aggiungere la segnalazione di un vecchio articolo di F. Antinucci, reperibile in rete:
http://www.infosys.it/info90/obbligo/antinucc.html
Nonostante si tratti di un intervento del '92, contiene molti spunti di riflessione su aspetti cognitivi e didattici...
Vorrei chiedere aiuto (anche solo come consulenza) perche' mi e' stato affidato, per l'anno venturo, nel nascente Liceo delle Scienze Sociali, la disciplina "nuovissima" di Linguaggi non verbali e multimediali. Ho qualche idea, ma mi piacerebbe molto discutere con tutti gli amici della rete. Le questioni sono: quale statuto ha la disciplina? su quali testi impostare l'insegnamento? quali competenze debbo sviluppare in me prima di tutto? Ecc. ecc. L'insegnamento prevede mediamente due ore settimanali (di cui una in compresenza di altri docenti).
Insegno italiano e storia da ventotto anni nelle superiori, sono laureato in lettere antiche, ho imparato, quasi da autodidatta a servirmi del PC e ho realizzato un CD ROM usando Multimedia ToolBook 3.0 Soprattutto per le competenze "informatiche" il preside mi ha affidato l'incarico.
Cosa potete fare per aiutarmi a
chiarire le idee e per accettare la sfida di "fondare lo
statuto" di una nuova disciplina curriculare come Linguaggi
non verbali e multimediali?
Grazie.
Andrea de Lisio
Ho realizzato progetti 1B, per alcune scuole medie, confrontandomi e collaborando con numerose associazioni del settore prevedendo tutto nei minimi dettagli: dal coinvolgimento degli insegnanti, al tipo di reti, al tipo di attrezzature; ad esempio in base alle normative vigenti una scuola non dovrebbe prendere un "assemblato in casa" perché non rispondente alle normative europee obbligatorie sulla sicurezza....ecc
insomma forse é più semplice
fartene avere una copia di riferimento vuoi?
Se desideri averla basta chiedere !
MACordialmente Americo Rocchi
Via la botte 110,03100 FROSINONE
TEL 0775/270980, 0347/3563053
Mi sono occupato dell'1b l'anno scorso per la mia scuola, l'Itis Alessandro Volta di Palermo.
Ho letto anche la replica di Americo Rocchi, e certo mi congratulo con lui per la puntigliosità con la quale ha svolto il suo lavoro. Mi pare anche di capire che la sua partecipazione sia stata di natura professionale.
La mia esperienza è piuttosto differente.
Il progetto da noi sviluppato non è sceso molto nei dettagli. Del resto la stessa modulistica richiesta dal Ministero non dava spazio ad una programmazione puntigliosa. La nostra richiesta indicava dunque quello che potrebbe chiamarsi una "lista di buone intenzioni" . . . e basta!
Il progetto comunque è stato approvato. Abbiamo già speso i soldi ed oggi disponiamo di un Nucleo Operativo per i Docenti e di una Aula Multimediale per gli studenti che, grazie anche al contributo diretto della scuola, risulta essere assai bene attrezzata e con potenzialità di utilizzo decisamente elevate.
A onor del vero devo riconoscere che una programmazione delle attività si rende ben presto necessaria, e infatti proprio su questo adesso stiamo lavorando.
Mi si consenta però di rilevare la assenza di qualsiasi notizia riguardante la prosecuzione del progetto: in particolare il Ministero dovrebbe a mio parere affrontare la questione del personale di assistenza tecnica
(assolutamente necessario se si vuole una reale agibilità delle strutture) e la assai spinosa questione riguardante gli eventuali incentivi da per i docenti che vogliano impegnarsi nella produzione di unità didattiche multimediali. Chiunque si sia cimentato in una opera di questo tipo sa infatti benissimo che lo sviluppo anche di un piccolo modulo richiede spesso decine e decine di ore di lavoro! Una retribuzione delle medesime (magari regolamentata da una verifica e/o inserita in progetti approvati dal Ministero) mi sembrerebbe adesso necessaria, opportuna e doverosa!
----------------------------------------------------------------------------
prof. Carlo Columba
Responsabile Centro Multimediale di Istituto e PSTD 1997-2000
Itis Alessandro Volta - Palermo
e-mail: mmvolta@tin.it
web: www.neomedia.it/volta
Vorrei per un attimo inserirmi nel
dibattito avviato dalla (trasparente?) polemica Mac - Win a cui,
a mio avviso, Mario Rotta ha dato una risposta piu' che esemplare
e convincente:
---------
Il nostro cervello e' l'unico software su cui dovremmo discutere.
---------
concordo pienamente. E vorrei aggiungere qualcosa.
Come insegnanti dovremmo discutere anche del cervello dei nostri alunni, o meglio di come imparano... In altre parole dovremmo discutere di modelli didattici.
Troppo spesso le accesissime discussioni sui sistemi operativi, sul software "migliore" ecc...nascondono la sostanziale mancanza di idee e proposte in ordine alla didattica e all'educazione (e anche il PSTD del Ministero non fa eccezione)
La domanda che dovremmo porci per prima e': cosa voglio fare insieme ai miei alunni con le tecnologie?
Continuare, con strumenti nuovi, a insegnare gli stessi contenuti (disciplinari) della scuola tradizionale?
Ma abbiamo mai fatto caso che in molte scuole dotate di reti si riproponelo stesso modello logistico - organizzativo dell'aula "classica"? (Server -cattedra, la lavagna alle spalle raramente manca. Stazioni multimediali come banchi disposti di fronte al server per l'insegnante...)
La tecnologia multimediale e la telematica offrono un'opportunità forse storica: cambiare contenuti e modalità di insegnamento - apprendimento nella scuola. Vogliamo sfruttare l'occasione?
E' pur vero che tecnologie diverse (hardware e software) portano con se' implicite proposte di modelli didattici diversi, ma non e' questo il punto da cui partire. A monte credo vadano fatta alcune scelte.
L'alunno dev'essere solo "lettore" o anche "autore"? Si deve anche imparare come funzionano i computer, o vogliamo servircene solamente come mezzi di comunicazione? A quale eta' e' giusto ed opportuno che i ragazzi imparino un linguaggio di programmazione? Cultura del calcolo o cultura della simulazione (v. articolo di S. Turkle sull'ultimo Telema)? E l'idea di "edutainment" e' solo una trovata commerciale o non porta con se' un principio pedagogico essenziale che ha a che fare con la motivazione ad apprendere?
Personalmente sono convinto che molte di queste domande non siano domande
nuove, molti di noi negli anni passati se le sono gia' poste e qualche (parzialissima) risposta qualcuno l'ha trovata (almeno per se'). L'anno di avvio di Multilab e del PSTD non e' l'anno zero delle tecnologie nella scuola.
Non voglio dilungarmi oltre.
A chi fosse interessato ad una trattazione un po' meno arruffata e confusa della questione (ho scritto proprio di getto) segnalo un mio testo in rete:
http://gruppoentasis.com/iperteca/diecianni.html
Alessandro Rabbone
Via Volta 67 10036 Settimo To
tel 011-8952882
rabbone@tin.it
Infatti nelle scuole superiori esistono tecnici di laboratorio ed insegnanti tecnico-pratici proprio in funzione di questa tua giusta constatazione.
>Purtroppo il Ministero PI, che
pure ringraziamo per l'iniziativa, non
>prevede di poter pagare personale per le mansioni ora
citate...
Il Ministro (insieme ai colleghi di governo) sa benissimo della necessità di tali figure, ma non pone la giusta priorità al problema. Di conseguenza non tira fuori un centesimo!
> e quindi mi pare ovvio che si
levi qualche voce per proporre sistemi Mac che sono
> indubbiamente più facili da gestire.
Guarda, se credi che la scelta di un ambiente (software ed hardware) possa minimizzare o evitare il problema di cui sopra, beh, credo proprio tu sia fuori strada. Non si tratta solo di maggiore o minore stabilità del s.o., di programmi e interfacce più facili o difficili, di disponibilità di software e di fastidiosi IRQ, DMA e I/O. C'è tutto un discorso di manutenzione, cura del materiale, riparazioni ed altro che rendono OVVIO (per una qualsiasi azienda) la presenza di figure specifiche.
Roberto Bergonzini
Ecco gli ipertesti in linea del Criadid:
Gio/Dizio, Dizionario del gergo
giovanile (a settembre lanciamo il progetto a tutte le scuole
Superiori!!)
http://www.criad.unibo.it/galarico/giodizio/index.htm
Come fa un docente a collaborare
al Criadid? Prendete esempio dalla prof.a Fabia Zanasi!!
Lo Studium a Bologna nel Medioevo: una Università costruita da
studenti.
http://www.criad.unibo.it/galarico/ZANASI/index.htm
I riti del cibo nell'antica Roma
http://www.criad.unibo.it/galarico/ZANASI/cibus/index.htm
"La Storia del calcolo
automatico e delle sue pratiche applicazioni" attende
suggerimenti da parte di docenti amanti dell'informatica e della
matematica!
http://www.criad.unibo.it/galarico/calcolo/index.htm
E' possibile fare in rete un
ipertesto sull'arte e l'architettura valorizzando la propria
citta'?
Visitate il Duomo di Cesena.
http://www.criad.unibo.it/galarico/duomo/index.htm
La sezione "Lingue
straniere" del Criadid attende i vostri contributi (inglese
e francese, ma anche spagnolo, russo...); quello del prof
Wolfgang Pruscha sulla sua Germania e' stato decisamente
superiore a ogni più rosea aspettativa...
http://www.criad.unibo.it/galarico/lingue/tedesco/tedesco.htm
"Smonta lo spot" è
stato sicuramente l'ipertesto più impegnativo di tutti, anche
per la notevole mole di ma-teriali. E' strutturato in modo tale
che può essere arricchito all'infinito. Decisivo il contributo
di Dario Cillo.
http://www.criad.unibo.it/galarico/ATUALITY/spot/smonta/spot.html
La Manon Lescaut di Puccini
Un ipertesto sulla musica classica? Si', ascoltando arie in
Realplayer.
http://www.criad.unibo.it/galarico/musica/index.htm
Anche uno studente (in questo caso
dei Geometri) se si mette puo' fare miracoli!
http://www.criad.unibo.it/galarico/arts/index.htm
La Sindone di Torino. Il reperto
più controverso della storia ora si può vedere nel Criadid.
http://www.criad.unibo.it/galarico/zetesis/sindone/sindone.htm
La caverna scolpita di
Deneze-sous-Doue'. Un caso di arte troglodita del XVI sec.!!!
http://www.criad.unibo.it/galarico/arts/deneze/index.htm
AMISTAD Il successo di una rivolta
di schiavi africani che ha lasciato il segno negli Stati Uniti!
http://www.criad.unibo.it/galarico/arts/amistad/index.htm
MALCOLM X. Un grande della
politica afroamericana.
http://www.criad.unibo.it/galarico/politica/malcolm/index.htm
Buona visione a tutti!
**************
http://www.criad.unibo.it/galarico
mailto:galarico@criad.unibo.it
mirror: http://www.scuolaitalia.com
Componente del Comitato Scientifico di Educazione&Scuola http://www.edscuola.com
Mi permetto di intervenire nel dibattito sugli ipertesti, dopo aver letto l'ultimo intervento (N.Scipione) e altri precedenti; confesso di non aver letto proprio tutti gli interventi degli ultimi mesi (ne arrivano anche 15-20 al giorno e non sempre ho il tempo di leggerli tutti e fino in fondo), e chiedo quindi scusa se mi capita di dire cose già dette da altri.
Come insegnante di Matematica e Informatica ho avviato una produzione di ipertesti da parte degli studenti; un'esperienza di grande interesse didattico: all'inizio c'e' molto entusiasmo, poi ci si rende conto che scrivere un ipertesto richiede tempo, lavoro e pazienza, e non e' facile mettere insieme un prodotto di qualita', ma comunque ci stiamo provando.
Ho allora speso un po' di tempo per visitare in rete altri "ipertesti"
prodotti da scuole e altre istituzioni; con molta delusione devo dire, ed e' il nocciolo del mio intervento, che il 90% di quello che ho finora trovato in rete sotto il nome di ipertesto, mi pare che con l'idea originale di ipertesto abbia poco o nulla a che vedere.
Sulla esatta definizione di ipertesto so che non tutti sono d'accordo; credo che la cosa migliore sia allora di andare a rileggersi l'articolo As We May Think scritto nel 1945 da Vannevar Bush (è in rete all'URL
http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/vbush ), considerato come l'antesignano dell'idea di ipertesto; Bush partiva da una domanda molto semplice: "come possiamo organizzare meglio l'enorme massa di conoscenze che la nostra civiltà produce?" e osservava che la struttura tradizionalmente usata per organizzare le conoscenze (o informazioni) e' l'indice semplice o strutturato in sotto indici (gli informatici la chiamano struttura ad albero o gerarchica), e che questa struttura non e' naturale e costringe ad un continuo andirinvieni tra indice e pagine; il cervello umano non funziona in questo modo ma piuttosto per associazione di idee, per nessi logici tra un'idea e l'altra; Bush proponeva allora il Memex una macchina ideale che doveva consentire di immagazzinare pagine, libri, immagini e di creare dinamicamente collegamenti per associazione di idee (trails) tra una pagina e l'altra.
L'idea di Bush fu poi ripresa venti anni dopo da T.Nelson che conio' la parola ipertesto (hyper-text); il sogno di Nelson era quello di realizzare un ipertesto universale, equivalente elettronico dell'enciclopedia universale.
Ora c'e' Internet, HTTP e HTML e tutti parlano di ipertesti, ma che cosa ritroviamo sotto questa etichetta? Ecco il paradosso: il 90% degli "ipertesti" che si trovano in rete sono organizzati secondo una struttura ad indice, proprio quella struttura che Bush voleva superare! Le sole ancore presenti sono quelle che mandano avanti e indietro tra le singole pagine e l'indice; a volte ci sono ancore tra una pagina e la successiva, chiara reminiscenza di una logica sequenziale. Scarsi e molto spesso del tutto inesistenti i collegamenti associativi preconizzati da Bush.
A questo punto mi pare evidente che chiamare ipertesti questi prodotti sia un vero e proprio travisamento dell'idea originale di ipertesto. Comunque lo si definisca un ipertesto deve essere un insieme di pagine collegate secondo una logica associativa (e' questo il fulcro dell'idea di ipertesto), e non solo secondo la logica degli indici o addirittura di una struttura sequenziale camuffata.
Puo' sembrare una questione formale, di definizioni, ma credo che la cosa sia anche e soprattutto sostanziale: l'ipertesto deve essere un nuovo modo di organizzare le conoscenze, e' un peccato che sotto questo nome vengano viceversa riproposte strutture tradizionali e inefficienti. Bisogna rivedere il modo di scrivere, scrivere non piu' in modo lineare, ma da ogni pagina farne nascere altre e poi individuare i nessi tra una pagina e l'altra ... questa e' la sfida che affrontiamo quando cerchiamo di mettere insieme un ipertesto ed e' una sfida difficile che mi pare abbia un grosso interesse didattico. E sono d'accordissimo con N.Scipione nel pensare che quella ipertestuale sia la struttura ideale per i futuri libri di testo (si pensi solo a tutte le connessioni "nascoste" che ci sono all'interno di un testo di Matematica).
Altra questione formale ma non solo formale e' la sistematica confusione che si fa tra gli aggettivi "multimediale" e "ipertestuale": non e' affatto la stessa cosa! Un prodotto multimediale e' un prodotto che mescola testo, immagini e a volte suoni e video; non e' poi una gran novita', anche un codice medioevale mescolava testo e immagini spesso con effetti raffinatissimi ed era dunque multimediale ante litteram, e prima ancora erano multimediali i papiri egizi! Un ipertesto e' una cosa ben diversa e puo' anche non contenere alcuna immagine; anzi quando contiene immagini e altri "effetti speciali" dovrebbe piuttosto essere chiamato ipermedia (hyper-media). Insomma quella di ipertesto e' un'idea nuova e importante, mentre molto meno nuova e importante mi sembra quella di multimedia (la ascriverei al genere del molto fumo e poco arrosto).
In conclusione il timore di fondo e' che Internet da grande occasione per realizzare l'enciclopedia universale sognata da Nelson si stia trasformando in una grande ammucchiata di materiali e pagine poco o punto connessi e che l'organizzazione delle nostre conoscenze invece di migliorare, diventi sempre piu' caotica e inestricabile.
Timore che si aggiunge e si mescola al problema sempre piu' serio dell'attendibilita' di Internet: l'altro giorno mentre effettuavo una ricerca in rete su Archimede mi sono imbattuto in una pagina dedicata al grande matematico siracusano che comincia testualmente cosi': "Archimede soprannominato pitagorico perche' fu allievo di Pitagora ..."; di fronte a cose del genere c'e' da chiedersi se Internet non rischia di essere travolta da una maggioranza di "asini" ormai incapaci di distinguere la storia dai fumetti, ma bravissimi nel mettere insieme "ipertesti" fatti soprattutto di effetti speciali e "multimediali". Ma qui mi fermo per non rimasticare quei timori che sono stati molto ben espressi nell'ormai notissimo e citatissimo "Segmenti e Bastoncini" di L.Russo.
Bene, temo che il mio intervento sia diventato davvero troppo lungo e, scusandomi di questa lunghezza mi congedo sperando almeno di aver stimolato qualche riflessione su questi temi.
Paolo Bonavoglia
-------------------------------------------------
Ginnasio Liceo "Marco Foscarini"
Cannaregio 4942
30131 VENEZIA
-------------------------------------------------
sito della scuola http://www.venis.it/~mfosc/index.shtml
Come non essere d'accordo? I richiami storici (Bush e Nelson) alle origini dei concetti, sono molto importanti e contribuiscono alla riflessione seria e costruttiva. Ci sono dei "pero'".
Innanzitutto penso che un certo "allargamento" del significato originale di un termine come "ipertesto" non sia poi un fatto cosi' negativo. Anch'io mi rendo conto che nel parlare quotidiano (a scuola) uso impropriamente "ipertesto" in luogo di "ipermedia" o "applicazione multimediale", pur essendo consapevole delle profonde differenze sostanziali elencate da Bonavoglia. Cosi' tuttavia va il linguaggio parlato... A volte, per essere piu' immediati, piu' semplici, per farsi capire, siamo costretti ad essere vaghi ed imprecisi.
Seconda questione: noi (insegnanti) parliamo di ipertesti in una situazione specificatamente scolastica. Cio' porta a conseguenze rilevanti. Riteniamo (o dovremmo ritenere) piu' importante del prodotto in se' il processo didattico - educativo che sta alla base della realizzazione del prodotto stesso.
In altre parole, a scuola non e' tanto importante che l'ipertesto (o ipermedia) diventi un "buon" prodotto, ma e' fondamentale che i ragazzi capiscano pienamente cio' che stanno facendo. L'importanza del "ragazzo autore" non sara' mai sottolineata abbastanza. Proprio perche' l'ipertesto e' un nuovo modo di organizzare le conoscenze, dovranno essere proprio i ragazzi a sceglierle, ad organizzarle, a gerarchizzarle e a dar loro forma (scritta, iconica, sonora...)
Questo ho l'impressione che non sempre avvenga. Quindi non mi preoccupa tanto la (pur reale) non - rispondenza ad un modello "ortodosso" di ipertesto. Mi preoccupano invece molte applicazioni i cui contenuti sono stati palesemente decisi dagli insegnanti... Mi guardo intorno e mi domando "e' mai possibile che agli studenti interessi sempre il proprio quartiere, l'ambiente, l'alimentazione...?"
Io lavoro in una scuola elementare e forse e' per questo che vedo le cose in maniera un po' diversa in fatto di ipertesti e multimedialita'.
Per me e' gia' un successo se riesco a far "capire" ai miei bambini che con un computer e' possibile costruire una "storia a bivi" simile, per struttura logica, a quella dei libri-game che leggono avidamente (non tutti). Non mi domando se il prodotto "storia a bivi" puo' essere classificato come ipertesto o come applicazione multimediale. Faccio male? Su altre parti vorrei ancora discutere.
> Insomma quella di ipertesto
e' un'idea nuova e importante,
> mentre molto meno nuova e importante mi sembra quella di
multimedia
> (la ascriverei al genere del molto fumo e poco arrosto).
Su questo non sono molto d'accordo, ma e' tardi e ho gia' scritto troppo. Rimando dunque ad altra data l'intervento sulla multimedialita'. Concludo segnalando la nascita del Web della scuola in cui lavoro (Brandizzo, prov. Torino).
Tra il resto ci sono dei tentativi
(ipertestuali? multimediali?) per tradurre in fatti quanto dicevo
prima....
Ciao a tutti
Alessandro Rabbone
rabbone@tin.it
Trovo davvero penose queste pseudo-discussioni che da una parte considerano la reticolarita' una proprieta' delle tecnologie anziche' del processo di conoscenza e dall'altra assolutizzano gli oggetti della conoscenza al di la' dei soggetti conoscenti....
Mi riservo di intervenire in modo
piu' articolato, ma basterebbe davvero voler leggere qualcosa di
diverso dai soliti manuali o dai testi dei neofiti e degli
entusiasti in genere per capire quale sia il vero rapporto tra
esigenze di tecnologie della conoscenza che appunto ne rispettino
le esigenze reticolari - libro rilegato -- ipertestualita'
(suggerisco due testi: a) Metamorfosi della scrittura" Nuova
Italia e "Internet dreams" Utet -Telecom).
Quella dell'escusivita' dei legami associativi e' poi una tesi
davvero curiosa!
Vedo che Giovanni Ferrero ha rovesciato diverse secchiate di
gelido e sano scetticismo sugli "entusiasti"
dell'ipertesto ... ma
>Idea che sembra sottointendere una impostazione nozionistica non tanto educativa.
Non capisco proprio dove stia l'impostazione nozionistica; a maggior ragione si potrebbe dire che un libro o un'enciclopedia sono nozionistici. Cosi' come non vedo come l'ipertesto possa indurre "superficialita'" nel lettore; forse perche' e' troppo facile "saltare" da una pagina all'altra?
E poi questa polemica sul nozionismo vecchia ormai di almeno trent'anni mi pare fuori luogo: non dimentichiamoci che le nozioni sono gli umili mattoni alla base di ogni conoscenza; p.es. se io conosco le regole grammaticali e la sintassi di una lingua ma non ho la nozionistica e mnemonica conoscenza di qualche migliaio di vocaboli di quella lingua, non potro' certo dire di "conoscere" quella lingua e di poterla utilizzare in pratica (situazione questa purtroppo molto diffusa nelle nostre scuole). Ma sto andando fuori del seminato ...
>Mi sembra che le connessioni
"nascoste" nella matematica siano troppe per
>entrare tutte in un ipertesto. Pensa solo ad un esercizio di
Geometria
>analitica, dove ogni passaggio algebrico corrisponde ad una
figura.
>Comunque ti faccio i migliori auguri per il lavoro che stai
facendo,
>ovviamente difficile e massacrante ma che, se riesce, puo'
finalmente
>indicare come costruire ipertesti civili.
>
Non sto certo pensando di realizzare ipertesti generalizzati ovvero enciclopedie universali che comprendano tutte le associazioni possibili e immaginabili; ma tra il tutto e il niente ci sono tante gradazioni intermedie, e credo si possano benissimo realizzare ipertesti con un bel numero di collegamenti ...
Certo l'ipertesto non si puo' mettere in tasca, non si puo' leggere in vaporetto, il monitor poi stanca gli occhi, il lavoro è massacrante, alla fine forse si rivelera' una bolla di sapone come tante manie didattiche degli ultimi decenni ... ma vogliamo almeno provarci prima di abbandonarci al facile sarcasmo e all'altrettanto facile scetticismo?
Accetto comunque gli auguri, ma vorrei capire cosa siano questi "ipertesti civili".
Paolo Bonavoglia
-------------------------------------------------
Ginnasio Liceo "Marco Foscarini"
Cannaregio 4942
30131 VENEZIA
Essendo chiamato in causa rispondo al seguente intervento di M.Guastavigna; devo pero' prima di tutto lamentare l'uso di termini come "penose" e "pseudo-discussioni" che non mi sembrano appropriate ad una ista di discussione. Quando mi ci sono iscritto alcuni mesi fa pensavo fosse una lista aperta al contributo di tutti e non limitata ad una cerchia di iniziati; il rispetto per tutti i partecipanti dovrebbe essere la regola n.1 in queste liste ...
>Trovo davvero penose queste
pseudo-discussioni che da una parte considerano
>la reticolarita' una proprieta' delle tecnologie anziche' del
processo di
>conoscenza e dall'altra assolutizzano gli oggetti della
conoscenza al di
>la' dei soggetti conoscenti....
Non so davvero dove io possa aver considerato la reticolarita' una "proprieta' delle tecnologie" ... ; ho solo detto che la reticolarità mi pare proprieta' caratteristica degli ipertesti e che sembra strano che vengano proposti come ipertesti cose che di reticolare non hanno nulla; di tecnologie non ho affatto parlato e allora i casi sono due: o Guastavigna considera l'ipertesto una tecnologia (cosa che mi pare strana, un ipertesto
potrebbe benissimo risiedere su carta, anche se la cosa sarebbe poco pratica o magari su microfilm come proponeva Bush) oppure il termine reticolare, che in Matematica e Informatica (le materie che insegno) ha un significato ben preciso, direi inequivocabile, ha per Guastavigna e per la sua disciplina (che ignoro) tutt'altra accezione, nel qual caso resto in attesa di lumi.
Ancor meno poi so dove abbia "assolutizzato gli oggetti della conoscenza al di la' dei soggetti conoscenti"; l'ipertesto per me e' solo un modello logico per organizzare e archiviare le conoscenze (o le informazioni) come possono esserlo i modelli classici dei data-base (gerarchico, reticolare, relazionale). E la reticolarita' e' propria anche degli ultimi due modelli.
>Mi riservo di intervenire in
modo piu' articolato, ma basterebbe davvero
>voler leggere qualcosa di diverso dai soliti manuali o dai
testi dei
>neofiti e degli entusiasti in genere per capire quale sia il
vero rapporto
>tra esigenze di tecnologie della conoscenza che appunto ne
rispettino le
>esigenze reticolari - libro rilegato -- ipertestualita'
(suggerisco due
>testi: a) Metamorfosi della scrittura" Nuova Italia e
"Internet dreams"
>Utet -Telecom).
Non capisco quali siano questi manuali di neofiti ed entusiasti; l'unico testo da me citato e' quello di Bush di 50 anni fa; si vede che Guastavigna ha capacita' divinatorie nell'indovinare le letture di persone che nemmeno conosce; per quanto riguarda il sottoscritto devo pero' dire che ha fallito il bersaglio, e di molto!
>Quella dell'escusivita' dei legami associativi e' poi una tesi davvero curiosa!
Ho solo ricalcato l'idea di Bush
che parlava semmai di superiorità dei collegamenti associativi
rispetto alle strutture ad indice.
E visto che ho di nuovo citato Bush, non posso fare a meno di
ricordare la sua capacita', che e' tipica di tutti i
"grandi", di spiegare le cose in un linguaggio che sia
il piu' semplice e chiaro possibile, ben diversa
dall'atteggiamento tipico delle Curie e delle Accademie, quello
di parlare "latino" di fronte agli estranei con
l'obiettivo piu' o meno recondito di confonderli e di
intimorirli.
Prendo comunque diligentemente nota dei testi suggeriti, anche se, fatto curioso, manca il nome dell'autore, e resto comunque in trepidante attesa del piu' articolato intevento di Marco Guastavigna.
Paolo Bonavoglia
-------------------------------------------------
Ginnasio Liceo "Marco Foscarini"
Cannaregio 4942
30131 VENEZIA
Ancora una volta trovo molto stimolanti le parole di Bonavoglia e credo che valga la pena di soffermarsi ancora un po' sui punti toccati (anche se forse sarebbe piu' opportuno farlo nella lista trasversale sulla multimedialita', a cui peraltro non sono iscritto)
> Perfettamente d'accordo
sull'importanza del "ragazzo autore" (e non
> passivo fruitore di lezioni ex-cathedra), un po' meno sulla
qualita' del
> prodotto (...ma io insegno in un liceo ...), e
sull'irrilevanza del tipo di
> lavoro prodotto (testo o ipertesto o altro).
>
Ma io sostengo proprio che la qualita' del prodotto e' essenziale!
Per questo insisto sul fatto che i contenuti devono essere il piu' possibile "farina del sacco" degli alunni. Sicuramente le differenze di interessi e di competenze culturali tra bambini di scuola elementare e ragazzi delle superiori e' abissale. L'importante e' tenere ben presente che un "contenuto" (sia questo la crittografia o un racconto di fantascienza) e' veramente compreso (anche nei suoi nessi logici interni) solo se ha un senso per il ragazzo.
Dove per "senso" intendo un interesse motivazionale che comprenda anche aspetti personali ed emotivi.
Rispetto al "tipo" di prodotto voglio solo dire che l'enorme e rapidissimo sviluppo tecnologico cui siamo sottoposti (e che, ci piaccia o no, e' in strettissima relazione con la nostra cultura e con il nostro modo di pensare e conoscere) non consente schematizzazioni e definizioni rigide.
Ho visitato un ipertesto della scuola di Bonavoglia (quello sulla crittografia. Complimenti, tra l'altro!) Che importanza ha sapere se mi trovo davanti ad un e-text, ad un ipertesto o altro, quando la comunicazione e' efficace, riesco a capire, ad interessarmi e, perche' no, anche a divertirmi, giocando con il codice di Vigenere?
> Assegnare la preparazione di
un ipertesto ad uno studente poteva essere un
> formidabile strumento per "costringerlo" a leggere
e comprendere a fondo un
> argomento, e il tutto in modo gratificante, e anche
appassionante.
>
Su questo ok.
> Quest'ultimo pericolo è
tanto piu' serio con Internet, dove con la massima
> facilita' si possono scaricare pagine, testi e immagini e
montarli senza
> neanche leggerli fino in fondo!
>
Ma non e' solo un pericolo! E' anche un vantaggio ed una possibilita' in piu'.
Questo e' il punto. Non e' piu' pensabile che si legga sempre tutto e che si comprenda sempre tutto. Non possiamo pretenderlo dai nostri studenti. Proprio Internet l'ha reso impossibile. Anzi direi che la funzione principale della scuola e' appunto questa: aiutare i ragazzi a capire quando e' necessario ed opportuno andare fino in fondo, quando "concentrarsi" e quando invece "scorrere velocemente", magari per trovare qualcosa d'interessante, secondo il proprio gusto o il proprio "senso".
> ma il vero pericolo e' che
questi ipertesti siano non solo
> decisi ... ma anche realizzati in toto dagli insegnanti;
finche' un
> insegnante propone un argomento non mi pare faccia nulla di
male, anzi mi
> pare che faccia in pieno il suo mestiere; o no?
>
Certamente, ma su questo ci sarebbe ancora molto da discutere... A me e' capitato, per esempio, anche di lavorare con bambini molto piccoli (5 anni). Questi hanno da proporre e da dire (se li si sa ascoltare) un sacco di cose originali e interessanti (almeno cosi' a me sembrano). Chiaramente la loro competenza di produzione multimediale era piuttosto limitata (ma cosi' hanno imparato tutti a scrivere).
Ho fatto una scelta. Anziche' pretendere un prodotto fatto "in toto" dai bambini, mi sono posto in una posizione di "collaboratore". Da ciascuno secondo le sue capacita'... Loro hanno prodotto i materiali "grezzi", sulla base dei loro contenuti, testi (brevissimi), voci registrate, soprattutto disegni ed io ho poi implementato il tutto usando ToolBook.
Naturalmente chiedevo a loro come "volevano" che venisse fuori il lavoro finale. In qualche caso ho anche dovuto fare delle "correzioni".
Ma l'aspetto didattico piu' interessante e' proprio stato questo: le discussioni con i bambini, il negoziare continuo, anche nei minimi dettagli, il senso complessivo del prodotto. Quello che e' venuto fuori forse non e' solo "farina del sacco" dei bambini, c'e' anche un po' di farina di adulti. Ma e' un male questo?
Alessandro Rabbone
rabbone@tin.it
Amici di lista, aiutatemi a chiarire le idee a proposito di ipertestualita' e ipermedialita'.
Cito testualmente le seguenti definizioni:
1-un ipertesto e' una forma di testo composta da blocchi di scrittura ed immagini collegati da link che permette una lettura non lineare o non sequenziale (P. Landow)
2-un ipermedia e' un documento organizzato in maniera ipertestuale e integra al suo interno diversi codici di comunicazione (testo, immagini, voci, film...) (N. Sala)
Allora mi sono chiesto:
Dizionari, enciclopedie, elenchi e similari sono media testuali ma per la loro organizzazione non lineare possono essere considerati in qualche modo ipertesti ?
Una rivista e' un medium che veicola testo e contemporaneamente immagini. Allora posso considerarla multimediale, anzi, ipermediale ?
Infine possiamo dire che un cd-rom con animazioni, immagini, suoni ecc. non e' multimediale o ipermediale ma e' un medium che veicola un messaggio ipermediale ?
Visto che ci siamo, consigliatemi qualche lettura chiarificatrice sull'argomento, magari non esageratamente dotta ma chiara.
Grazie per la collaborazione. Auguro a tutti una buona estate.
Cordialmente
Paolo Boscolo. paolob@cbn.iperv.it
Provo a rispondere, anche se temo di aver gia' disquisito abbastanza sul concetto di ipertesto nei miei precedenti interventi; piu' che a una definizione formale, e' forse meglio arrivare a un insieme minimo di proprieta' che un prodotto deve possedere per potersi dire "ipertesto" nella lettera e nello spirito, che potrebbe essere:
a) devono esistere piu' itinerari possibili di lettura; se ne esiste uno solo, piu' o meno camuffato, siamo di fronte ad un testo lineare; tanti piu' sono gli itinerari possibili, tanto piu' ipertestuale il prodotto.
a1) la lettura deve poter cominciare da una pagina qualsiasi; la "home page" e' un utile punto di riferimento non una partenza obbligata; non dimentichiamo poi che il navigatore in rete puo' approdare ad una qualsiasi pagina come risultato di una ricerca con Altavista, HotBot o simili ...
b) ogni pagina deve essere accessibile in diversi modi, da molte altre pagine e deve dare accesso a molte altre pagine. In altre parole non dovrebbero esistere "rami secchi" o "cul de sac" ovvero pagine senza collegamenti o con il solo rimando all'indietro.
Chiaro poi che e' l'enciclopedia il modello ideale di ipertesto, e comunque e' quello a cui si ispiro' Ted Nelson nel 1965 quando conio' il termine hypertext.
Una pagina utile (se l'inglese non e' un problema) per ripercorrere la storia dell'idea di ipertesto e' quella realizzata da Jakob Nielsen della Sun Microsystem:
http://www.useit.com/alertbox/history.html
dalla quale si puo' tra l'altro accedere agli atti dei diversi convegni Hypertext dal 1987 in poi; purtroppo di molti interventi sono disponibili solo gli "abstract" ma e' comunque una navigazione interessante.
Paolo Bonavoglia
-------------------------------------------------
Ginnasio Liceo "Marco Foscarini"
Cannaregio 4942
30131 VENEZIA
Torna a modulo3.htm